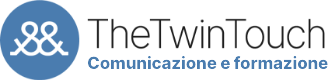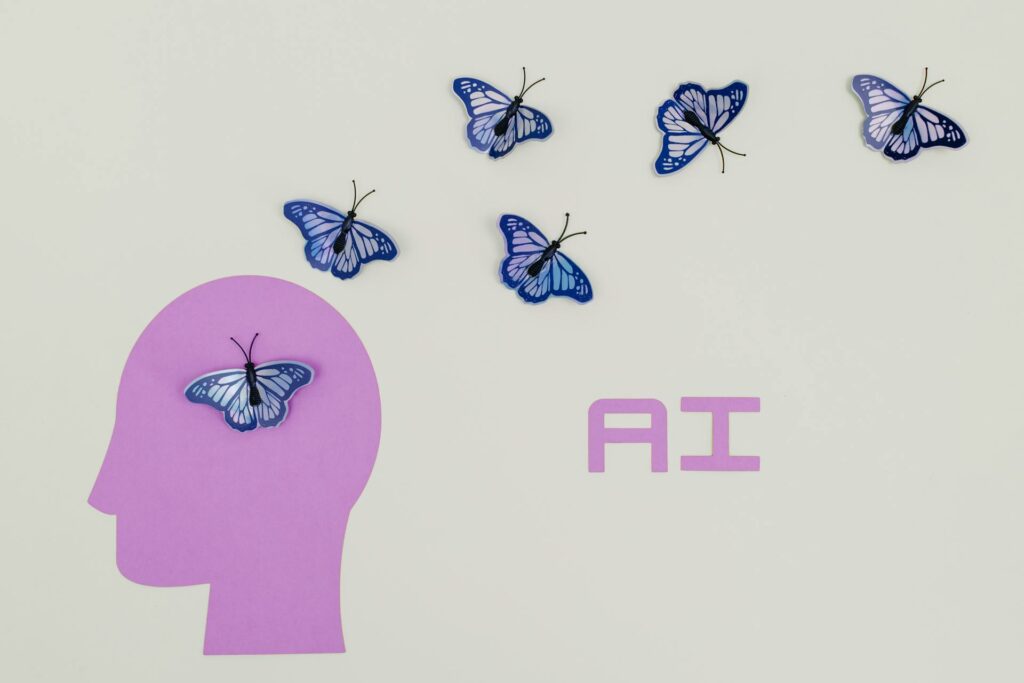La prima dummy sono io: credo di aver studiato qualcosa di correlato al funzionamento del corpo umano alle medie in scienze. Poi, il vuoto.
Ma quando ho iniziato ad avvicinarmi all’intelligenza artificiale, mi ha subito affascinato il legame tra cervello umano e AI. In una conferenza che ho ascoltato tempo fa, Mario Rasetti afferma “non serve conoscere il motore per guidare una macchina” – lo dice lui che è professore emerito al Politecnico di Torino, ed è vero, perché per scrivere un prompt efficace non serve conoscere cosa sono machine e deep learning, l’apprendimento per rinforzo, la tokenizzazione (lui comunque lo sa). Però per me sta proprio lì il bello.
Capire come l’intelligenza artificiale riproduce il funzionamento del nostro cervello. E me lo sono semplificato in questo modo:
nel nostro cervello, un segnale elettrico arriva ai dendriti (che possiamo immaginare come dei “rametti”) di un neurone. Ogni segnale ha un peso (cioè un’importanza variabile) e, se la somma di questi pesi supera una certa soglia, il neurone si attiva – generando una scarica che percorre l’assone (una sorta di “cavetto” di trasmissione) fino a raggiungere altri neuroni.
Allo stesso modo, in un modello di AI come DeepSeek, l’input (il nostro prompt, scomposto in token, cioè unità di testo) arriva a un percettrone (il “neurone artificiale”). Qui, invece di una soglia fissa, c’è un calcolo delle probabilità: gli input più rilevanti, in base ai dati appresi durante l’addestramento, vengono selezionati per contribuire alla risposta.
In altre parole, così come nel cervello solo alcuni segnali superano la soglia e proseguono, nell’AI solo le informazioni con la probabilità più alta di essere pertinenti vengono utilizzate per generare l’output finale: la risposta che il modello ci restituisce.